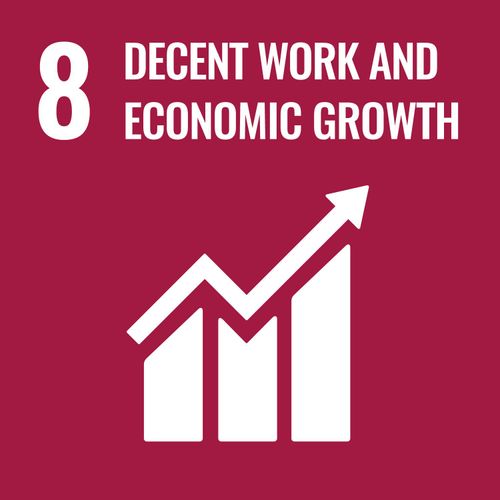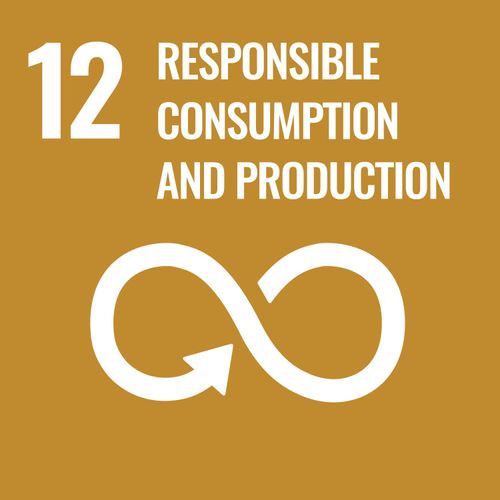Cosa possono fare i Paesi industrializzati per l’economia circolare?
Stahel: I Paesi industrializzati devono ridurre di dieci volte il loro consumo di materiali e di energia, vale a dire del 90%. Solo così permetteranno alle popolazioni dei Paesi più poveri di soddisfare i loro bisogni primari di sanità, istruzione, alimentazione, alloggio, sicurezza e mobilità, senza accrescere la massa globale di infrastrutture e di beni.
Nel 2020 questa massa di oggetti fabbricati aveva già superato la quantità della biomassa. Se dovesse crescere ancora, la biodiversità e la biomassa del pianeta subirebbero un inesorabile impoverimento, con conseguenze devastanti per tutti noi. Aumenterebbe in egual misura anche il consumo mondiale di combustibili fossili e quindi le emissioni carboniche. Secondo l’OCSE e l’IEA, questa energia viene sovvenzionata con 5000 miliardi di dollari l’anno per abbassare i costi delle distanze dell’economia della produzione globale e ammortizzare l’impatto dei costi di riscaldamento e dei veicoli.
Per la Svizzera l’economia circolare si tradurrebbe in enormi vantaggi: non disponendo di altre risorse oltre l’elettricità, ridurrebbe drasticamente la nostra dipendenza dalle importazioni, aumentando la resilienza nazionale.
Che ruolo hanno nell’economia circolare i fattori culturali?
Stahel: Hanno un impatto significativo sul nostro comportamento in relazione all’utilizzo delle risorse e alla riduzione dei rifiuti. Il singolo deve ripensare le sue abitudini in un’ottica di forte ridimensionamento dei bisogni e di rinuncia. A fare scuola in tal senso è il Giappone: il mottainai è uno stile di vita che esprime un sentimento di rammarico per aver sprecato una risorsa o un bene. Anche la politica deve cambiare mentalità e, anziché usare slogan – solo in parte efficaci – sulla neutralità carbonica o sull’azzeramento dei consumi delle risorse, agire per mantenere il più a lungo possibile il valore e l’utilità di un bene. Tuttavia, una pianificazione finanziaria nel breve termine porta a trascurare i lavori di manutenzione, con un successivo aggravio di spese e rischi enormi legati per esempio al crollo di ponti.
Quali sono i maggiori ostacoli per le imprese nella transizione a un’economia circolare?
Stahel: Le normative per la promozione della società industrializzata ostacolano questo modello economico. Penso alla tassazione sul lavoro umano anziché sul consumo di risorse, all’applicazione delle imposte sul valore aggiunto anche alle attività dell’economia circolare che mantengono il valore del bene o al risarcimento in base al valore attuale del bene anziché al costo reale di sostituzione in caso di danni coperti da responsabilità civile.
C’è poi anche tanta ignoranza nella gestione aziendale, nelle imprese e nella consulenza. Il più delle volte si dimentica che la rigenerazione dei beni (remanufacture) ha un ritorno di investimento (ROI) cinque volte superiore alla loro produzione. Manca anche un’adeguata compliance normativa nell’economia.
Sta chiedendo ai manager delle aziende un cambio di paradigma?
Stahel: L’economia circolare ha un effetto dirompente e richiede quindi che chi gestisce l’impresa scelga di abbandonare il business as usual. Occorre emanciparsi dal vecchio mantra del ridurre il più possibile i costi di produzione a favore di un’ottimizzazione dei costi lungo tutto il ciclo di vita che aumenti la competitività grazie a costi di utilizzo più bassi. Una struttura modulare con componenti standardizzati abbatte i costi e i rischi nella manutenzione dei beni e riduce i costi di formazione del personale e di stoccaggio dei ricambi, come ha dimostrato il caso Airbus. Gli approcci validi non mancano anche in tante altre aziende.
Dove crede ci siano le innovazioni più promettenti?
Stahel: I tessili sono la nuova plastica! Svizzera ed Europa stanno sviluppando senza sosta nuove tecnologie per il recupero di fibre di ogni tipo: viscosa, lana o cotone. La Climatex di Altendorf, nel Canton Svitto, ha sviluppato un processo per separare i filati misti in base alla tipologia. Invece di diventare un rifiuto problematico a livello globale, come accade al 99% di tutti i tessili, al termine del ciclo di vita i materiali di Climatex sono reintrodotti nei rispettivi cicli e riutilizzati di volta in volta.
Tuttavia, le risorse non rinnovabili più importanti dal punto di vista quantitativo sono il calcestruzzo, l’asfalto e l’acciaio. Oggi il Wirtgen Group, specialista in macchinari per l’edilizia, scarifica l’asfalto dalle pavimentazioni stradali e lo usa per creare nuove superfici. In futuro sarebbe importante anche isolare le leghe di acciaio per tipo in modo da consentire un riciclo ecologico dell’acciaio. Una separazione di questo tipo al momento non esiste ancora.
Altro esempio è quello dei ricercatori del politecnico di Zurigo che hanno scoperto per caso un nuovo polimero circolare: il polifenilenemetilene (PPM). Questo materiale sintetico fluorescente protegge i metalli dalla corrosione, si ripara da solo ed è in grado di evidenziare danni allo strato protettivo illuminandosi.
A che punto saremo tra dieci anni con l’economia circolare?
Stahel: Le normative internazionali a livello europeo come il regolamento Critical Raw Material Act (CRMA), i nuovi requisiti ESG e i dazi punitivi applicati ai prodotti industriali e alle risorse energetiche e materiali rappresentano per gli attori locali dell’economia circolare un vantaggio finanziario rispetto alla produzione globale lineare. Questa tendenza positiva si rafforzerà.
In futuro le aziende svilupperanno sempre più soluzioni di sistema anziché prodotti. Le start-up introdurranno sul mercato soluzioni del tutto nuove come sta avvenendo con la costruzione e la gestione di celle frigorifere in leasing nelle aree rurali dell’India da parte di BASE, una fondazione di Basilea. Nel complesso aumenterà la ricerca sul campo delle scienze dei materiali circolari.